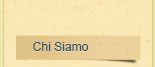Il sogno, cioè il ricordo del sogno, riaffiora alla razionalità affinché, anche attraverso di essa, possiamo svolgere un lavoro di reintegrazione della coscienza. E’ così che, agli occhi della nostra identità razionale, il ricordo del sogno risulta incomprensibile e misterioso, ma allo stesso tempo rappresenta potenzialmente un prezioso apportatore di consigli e messaggi da parte del nostro “maestro interiore”: ci offre prospettive diverse, punti di osservazione dai quali ciò che credevamo un problema smette di esserlo.
Il carattere così sfuggente, così difficilmente definibile, così poco scientifico del linguaggio dei sogni, lascia campo libero a chi si improvvisa “psicanalista fai-da-te” o che ostentando un miracoloso intuito spesso illusorio, senza alcun criterio se non appunto la propria presunta empatia quasi paranormale, spara assurdità risultando controproducente se non deleterio nei confronti di chi magari gli si affidava. All’altra estremità ci sono poi la smorfia e tutti i suoi derivati che assegnano banalmente un significato univoco ad ogni simbolo onirico.
E’ bene allontanarsi da entrambi questi approcci, e capire innanzitutto un concetto fondamentale: i sogni NON si possono tradurre ma solo interpretare. Si può tradurre un testo dal cinese all’italiano, perché la struttura del pensiero razionale è sostanzialmente la stessa e ciò permette di esprimere gli stessi concetti con linguaggi diversi. Il sogno è però generato da una dinamica di pensiero che risponde ad altre logiche: è molto più simile ad un messaggio espresso attraverso sole immagini. Sono due dimensioni diverse e una qualunque traduzione non potrà che essere tragicamente soggettiva e approssimativa.
Per questo motivo si parla di “interpretazione” e non di “traduzione”.
Non esiste quindi un “dizionario” simbolico universale, a maggior ragione considerando che i significati simbolici sono subordinati, in ordine di importanza, alle differenze culturali, sociali, generazionali, e individuali. Ci sono simboli “più universali” di altri, come il cielo, il mare, il sole, nella misura in cui essi sono radicati nella memoria genetica dell’umanità. Simboli come il cellulare, il tostapane, la tv hanno palesemente un valore differente a seconda del contesto storico e culturale. Ciò che può definirsi universale è il criterio di comprensione di una qualunque simbologia. Nella nostra cultura, ad esempio, soprattutto per l’ultima generazione, il cellulare è ormai per antonomasia simbolo di comunicazione. In una ipotetica tribù ove si comunica ancora con i segnali di fumo avremmo dei sogni molto diversi. L’interprete deve considerare questi aspetti per cogliere il senso fondamentale ed il denominatore comune di un oggetto ed estrapolarne la valenza simbolica.
E’ chiaro comunque che la capacità di comprendere i sogni non dovrebbe essere una competenza posseduta da poche persone, se il sognare è un’esperienza universale per il genere umano. La capacità di comprendere i sogni è insita in noi, solo che va in certa misura re-imparata. Soprattutto, è necessario recuperare una visione più oggettiva delle cose del mondo, priva di giudizi soggettivi e preconfezionati; sforzarsi di comprendere l’altrui sentire e l’altrui punto di vista anche quando divergono dai nostri. Avere una buona conoscenza teorica e dei criteri di interpretazione è un presupposto fondamentale per lasciare spazio all’intuizione: l’interprete deve saper miscelare in modo equilibrato razionalità e intuito. E’ così che lo sforzo necessario a comprendere i sogni costituisce una importante ginnastica interiore che agevola l’espansione della coscienza, l’elasticità mentale ed una visione più ampia e profonda della realtà in cui viviamo.
Non è una scienza esatta e non c’è nulla da dimostrare, né lo scopo è fare spettacolo. E’ un’indagine, uno scambio di informazioni che dovrebbe essere proficuo e che pretende pazienza.
Non si raccontano mai i propri sogni – specie quelli che ci hanno colpito – con leggerezza, ma solo all’interno di un rapporto d’intimità e di sicurezza perché narrarli vuol dire mettere a nudo ed esporre la propria soggettività, emersa nel sonno cioè in un momento di grande vulnerabilità.
Non è possibile pervenire alla “soluzione”, non esistendo alcuna “soluzione”.
Non esiste un’interpretazione giusta ed una sbagliata... possiamo parlare in termini di efficacia, di utilità.
Dice Jung:
“...la vera e propria interpretazione del sogno, è di regola un compito arduo. Essa presuppone penetrazione psicologica, capacità di combinare insieme cose diverse, intuizione, conoscenza del mondo e degli uomini e soprattutto conoscenze specifiche che implicano tanto nozioni assai estese quanto una certa “intelligence du coeur”. (...) Bisogna respingere l’interpretazione stereotipa di motivi onirici; gli unici giustificati sono significati specifici, deducibili attraverso accurati rilevamenti contestuali. Anche chi possiede una grande esperienza in questo settore è pur sempre costretto a riconoscere la propria ignoranza dinanzi ad ogni sogno e, rinunciando a tutte le opinioni preconcette, a predisporsi a un qualcosa di completamente inatteso.(...)
Cioè, un’interpretazione è utile ed efficace quando agevola la comprensione, la realizzazione di qualcosa di NUOVO da parte del sognatore: un’idea, un punto di osservazione che prima gli erano preclusi. Possiamo fare un’interpretazione brillantissima, fine ed accurata, ma se non aggiungiamo niente a quello che il sognatore già sapeva, non è servita a nulla. Ugualmente inutile impantanarci in mille dettagli che il sognatore non riconosce come suoi.

Copyright ventungrammi