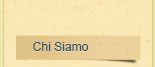Secondo Freud i sogni sarebbero una valvola di sfogo per impulsi, desideri, frustrazioni, voglie, “pulsioni” che reprimiamo quotidianamente a causa del nostro personale sistema di tabù etici e morali; in sostanza per lui tutto sarebbe riconducibile alla repressione sessuale. Di conseguenza il linguaggio dei sogni per Freud sarebbe un linguaggio artificioso, che la mente inventa per nascondere al sognatore il vero significato delle proprie visioni oniriche, in quanto razionalmente non sopporterebbe il peso dì verità inaccettabilmente sconvenienti.
In seguito Jung comprese che il linguaggio dei sogni non è affatto una derivazione distorta di qualcos’altro, ma al contrario è IL linguaggio primevo della coscienza: i simboli attraverso cui si esprimono i sogni possono essere considerati i mattoni elementari dell’attività cognitiva, gli enzimi attraverso cui sintetizziamo la realtà complessa in cui viviamo, nella veglia oltre che nel sonno. Un simbolo è la sintesi di innumerevoli oggetti, idee, forme: è l’essenza che li accomuna; il linguaggio dei sogni, come ricorda Fromm (1995), è forse l’unico vero linguaggio universale la cui grammatica è rimasta immutata nel corso dei secoli e in tutte le civiltà.
Comprendere il Mistero del Sogno
Perché dunque non lo comprendiamo?
Come scoprì Jung, non è il linguaggio dei sogni ad essere distorto ed incomprensibile, ma è la nostra mente razionale a non essere più in grado di sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda adatta a comprenderlo. Fin dall’infanzia il mondo ci abitua a prendere per ovvie le cose che ci vengono inculcate dal contesto famigliare e sociale in cui cresciamo. Aspettative, sensi di colpa, paradigmi limitanti... quella che potremmo chiamare con un neologismo “educastrazione” ci porta a costruirci una personalità artefatta e limitata, una struttura artificiosa senza la quale temiamo di sentirci nudi e vulnerabili e che difendiamo con le unghie e coi denti. Di conseguenza la maturazione, le potenzialità individuali, la ricerca della serenità, per non parlare della crescita interiore e spirituale, vengono inibiti da questi freni evolutivi e relegati in quel limbo che non corrisponde a nulla di “ciò che io sono” ma che paradossalmente rappresenta la parte più vasta del nostro essere. Ci troviamo così a vivere una tragica ed illusoria separazione tra il conscio e l’inconscio, tra la razionalità e l’istinto, tra ciò che siamo e ciò che crediamo di essere, tra l’essere e l’apparire.
Tra il Total ed il Nagual, come direbbe Castaneda.
Molto più dello “sfiatatoio” di Freud, il sogno secondo Jung è un lavoro che la coscienza profonda svolge nel sonno allo scopo principale di rimarginare questa ferita, di riordinare ed assimilare i contenuti cognitivi in un’ottica di completezza ed integrità. Una riorganizzazione che coinvolge l’essenza del sognatore nella sua totalità sia come individuo che come parte di una collettività, attraverso un processo non razionale, libero dalla morsa limitante dell’identità.
Si dice che gli illuminati non hanno la necessità di sognare, proprio perché padroni di uno stato dell’essere integro e completo, in piena coscienza.
A questo punto è però molto importante distinguere questo lavoro di riorganizzazione e di integrazione, che possiamo genericamente definire “attività onirica”, da quello che noi chiamiamo “sogno”.
Quello che possiamo raccontare agli altri è in verità solo il ricordo più o meno parziale di questa particolare esperienza interiore, un residuo razionalizzato di qualcosa affatto razionale.
Lo stato di coscienza da cui scaturisce l’attività onirica è ben diverso da quello logico-razionale della veglia ed è caratterizzato da quello che possiamo definire “pensiero metaforico”, un processo di elaborazione basato sull’immagine anziché sul verbo.

Copyright ventungrammi