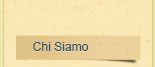Ricerca Spirituale
Attorno al Sogno e al Sognare
Indulgiamo ogni tanto nel ricordo di un sogno, nel raccontarlo a qualcun altro o anche solo ripercorrendolo nei nostri pensieri. E ricorre in noi quella strana sensazione, talvolta intensa, talvolta fievole, come di aver scavalcato una finestra aperta verso un mondo diverso, sospesa in un limbo indefinito, anche noi sospesi protagonisti di avvenimenti incomprensibili, osservatori di scene che cambiano repentine, di memorie non nostre, di vasti reami senza confini.E a pensarci non riusciamo a ricordare come l’abbiamo raggiunta quella finestra, come si sia aperta nel nostro mondo, tutto prosegue linearmente, il sogno e i suoi abitanti disegni di fumo che inascoltati svaniscono, un’eco che si perde tra i monti, presto irrimediabile silenzio.
Resta a volte il fantasma di un’emozione a colorare la giornata.
Quasi sempre accantoniamo i sogni per dar spazio alle cose “vere e tangibili” della vita quotidiana. I sogni in genere vengono poco considerati, dispersi nella dimenticanza, in quanto cose di poco conto, inutili, o comunque incomprensibili.
Secondo la moderna neurobiologia i contenuti onirici non hanno significato: sarebbero la materia di scarto dell’attività cognitiva della veglia. Una massiccia letteratura sull’argomento e la storia dell’umanità anzichenò, confutano senza fatica questa affermazione.
Sempre nella storia e in tutte le culture, nella quasi totalità dei casi, al sogno veniva data un’origine divina, diabolica, o divinatoria: un’informazione o un’ispirazione, proveniente da una fonte metafisica, oltre l’uomo o comunque oltre la coscienza ordinaria.
Prima dell’avvento della razionalità scientista occidentale e in quelle culture (le sciamaniche prime fra tutte) che ancora oggi ne sono relativamente lontane e dove il sentimento mistico e spirituale prevale, il sogno è stato ed è uno strumento consapevole e volontario di “lavoro” interiore e spirituale, di diagnosi e di guarigione, di iniziazione, di discernimento nelle importanti questioni della vita individuale e collettiva.
Nel contesto scientifico, come per tutto ciò che riguarda il funzionamento della mente, non esiste una scienza esatta, ma una serie di basi teoriche e relativi approcci metodologici, spesso contrastanti fra loro, attorno ai quali sono state scritte intere biblioteche.
Sul senso e significato del sogno bisticciano attraverso i secoli molti esperti e meno esperti, dall’oracolo di Delfi a Freud, agli oniromanzia della nuova era.
Ma come sempre, la verità sta nel mezzo: anche in questo ambito la scienza e la tradizione sono destinate a convergere lentamente verso una complementarità inevitabile, verso una visione più ampia ed elevata dell’uomo come parte integrante di un Universo fatto di sostanza sottile ed intangibile molto più che di solida materia e verso una coscienza più vasta delle leggi che lo governano.
Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, indiscussi protagonisti dell’approccio scientifico-razionale in questo ambito, ci accompagnano verso questa convergenza proprio mostrandoci come la comprensione del fenomeno onirico nella nostra (presuntuosa) cultura si sia evoluta negli ultimi cento anni.
Primo scienziato occidentale a dar valore al sogno e ad utilizzarlo come strumento terapeutico, Freud si sforzò di trovargli un senso ed una spiegazione e, seppur sbagliando a causa dei propri condizionamenti, funse da determinante stimolo creativo per Jung, il quale riuscì a penetrare più in profondità il mistero del sogno, divenendo il genitore di un auspicabile approccio “mistico-scientifico”.

Copyright ventungrammi